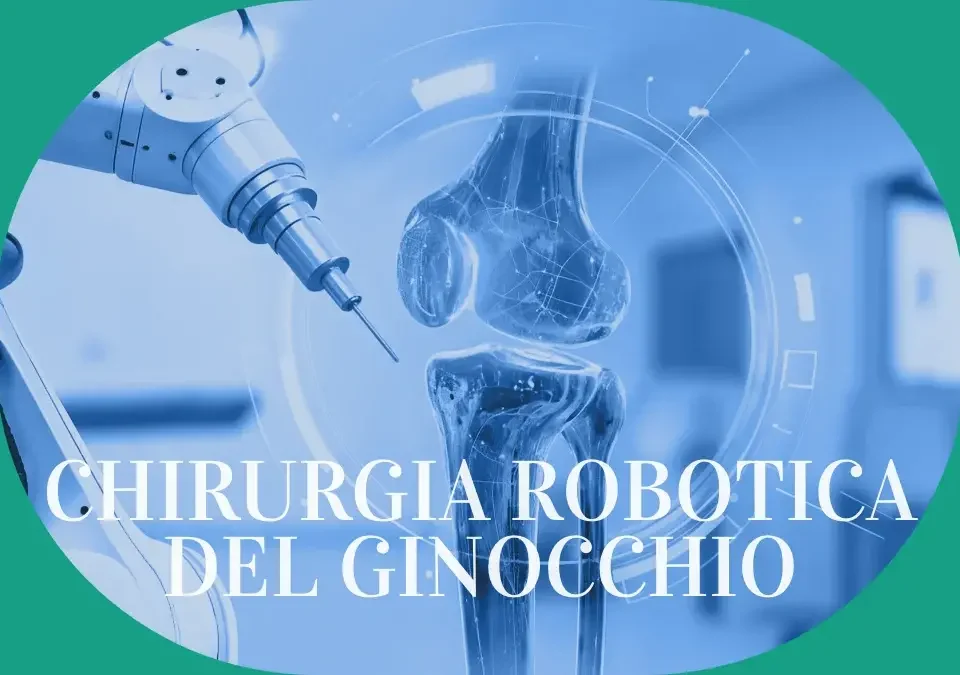LCM Ginocchio: Lesione del Legamento Collaterale Mediale
16 Aprile 2025
Fisiokinesiterapista: chi è, cosa fa e cosa cura con la fisiokinesiterapia
27 Giugno 2025Con questo articolo diamo la definizione di sclerosi del tetto acetabolare, andando a chiarire definitivamente tutti i dubbi su come si manifesta, quali sono quindi i sintomi della sclerosi dei tetti acetabolari, perchè prende questo nome e quali trattamenti vengono messi in pratica per risolvere questa patologia che colpisce l’osso subcondrale.
La sclerosi del tetto acetabolare è una condizione che colpisce l’articolazione dell’anca, causando dolore e limitazioni nei movimenti.
Si tratta di un ispessimento dell’osso subcondrale, ovvero lo strato di osso appena sotto la cartilagine, nella parte superiore dell’acetabolo, la cavità che accoglie la testa del femore, per questo prende il nome anche di sclerosi acetabolare o sclerosi subcondrale dei tetti acetabolari.
Anatomia dell’anca
Per avere un quadro ben definito e comprendere a pieno la sclerosi del tetto acetabolare iniziamo dalle basi, andando a vedere l’anatomia dell’anca, cos’è il tetto acetabolare e qual è la sua funzione.
L’anca è un’articolazione cruciale che collega la gamba al bacino, permettendoci di camminare, correre e compiere una vasta gamma di movimenti. Al suo centro, troviamo l’acetabolo, una cavità a forma di coppa situata nell’osso del bacino.
Cos’è il tetto acetabolare?
Nell’anca è presente una rientranza, puoi immaginarla come una “coppa”. Ecco questa parte è l’acetabolo.
L’acetabolo ha la funzione principale è quella di accogliere la testa del femore, l’osso della coscia, creando un’articolazione a sfera che consente un’ampia mobilità.
I margini superiori dell’acetabolo prendono il nome di cigli acetabolari.
I cigli acetabolari hanno l’importante ruolo di mantenere la testa del femore ben posizionata all’interno dell’acetabolo, contribuendo alla stabilità dell’anca.
Il tetto acetabolare è la zona che sopporta la maggior parte del carico quando siamo in piedi o ci muoviamo e la riconosciamo come la parte superiore dell’acetabolo, la rientranza di cui parlavamo prima.
A causa di questo carico costante, il tetto acetabolare è particolarmente soggetto a usura e degenerazione, specialmente con l’avanzare dell’età, fino ad arrivare alla sclerosi del tetto acetabolare.
Capiamo quindi che il tetto acetabolare svolge una funzione importantissima per la nostra mobilità.
Vediamo come la sclerosi del tetto acetabolare può compromettere le normali attività che eseguiamo tutti i giorni, arrecandoci dolore e fastidi a volte, limitandoci nei movimenti.
Cos’è la sclerosi dei tetti acetabolari?
Possiamo dare una definizione di sclerosi dei tetti acetabolari andando a scomporre questa parola:
- Sclerosi: in medicina, indica un indurimento o un ispessimento di un tessuto. Se fa riferimento ad un’articolazione prende il nome di sclerosi articolare. In questo caso, riferendoci all’osso, la sclerosi prende il nome di sclerosi subcondrale.
- Tetti acetabolari: come abbiamo visto sopra il tetto acetabolare è la parte superiore dell’acetabolo, la cavità del bacino in cui si inserisce la testa del femore.
Quindi, la sclerosi dei tetti acetabolari, o sclerosi subcondrale dei tetti acetabolari, è un processo in cui l’osso si ispessisce e diventa più denso a causa della perdita di cartilagine e della conseguente crescita di tessuto cicatriziale.
Differenza tra sclerosi subcondrale e sclerosi tetti acetabolari
C’è una chiara distinzione tra la sclerosi subcondrolare e la sclerosi del tetto acetabolare, anche se sono strattamente correlati.
La differenza risiede unicamente nella specificità anatomica.
La sclerosi subcondrale descrive un aumento della densità ossea (indurimento) nell’osso subcondrale, ovvero lo strato di osso immediatamente sotto la cartilagine articolare, di qualsiasi articolazione, non solo dell’anca.
Mentre la sclerosi del tetto acetabolare è la manifestazione di tale fenomeno in una specifica parte dell’anca, quella dei tetti acetabolari, per questo viene denominata anche sclerosi acetabolo o sclerosi subcondrale del tetto acetabolare.
Cause della Sclerosi del tetto acetabolare
Il sovraccarico articolare, dovuto a obesità, attività fisiche intense o lavori che richiedono di stare in piedi a lungo, sottopone l’anca ad uno stress eccessivo che favorisce l’insorgenza della sclerosi dei tetti acetabolari.
Altre cause che possono agevolare la comparsa di questa condizione sono i traumi pregressi come fratture o lesioni dell’anca. Queste infatti possono alterare la biomeccanica articolare e predisporre alla sclerosi. Altra causa è la componente genetica, che può giocare un ruolo importante, rendendo alcuni individui più suscettibili allo sviluppo della patologia.
Infine arriviamo all’artrosi dell’anca. La sclerosi del tetto acetabolare in un paziente, è infatti, un chiaro segnale di allarme per la coxartrosi, ovvero l’artrosi dell’anca.
Coxartrosi bilaterale con sclerosi dei tetti acetabolari
La coxartrosi bilaterale è la causa principale della sclerosi dei tetti acetabolari.
La sclerosi tetto acetabolare, è infatti un reperto radiografico comune nei pazienti affetti da coxartrosi, una malattia degenerativa che porta alla progressiva usura della cartilagine articolare.
La coxartrosi, progressivamente consuma la cartilagine articolare, provocando un aumento del carico sull’osso subcondrale. Questo aumento del carico stimola l’osso a reagire, ispessendosi e diventando più denso, arrivando alla sclerosi del tetto acetabolare.
In sintesi, quando la cartilagine si consuma a causa della coxartrosi, la testa del femore sfrega direttamente contro i tetti acetabolari dell’anca, ormai privi del cuscinetto cartilagineo che attutiva il peso. Di conseguenza, tutto il carico si trasferisce sull’osso, che reagisce ispessendosi e dando origine alla sclerosi dei tetti acetabolari.
Anche i cigli acetabolari sono coinvolti nei cambiamenti degenerativi dell’anca che possono ispessirsi, deformarsi diventando più evidenti nelle radiografie e contribuire alla limitazione dei movimenti e al dolore nel paziente con coxartrosi o coxartrosi bilaterale.
La diagnosi di sclerosi dei tetti acetabolari, attraverso radiografie, può quindi essere un indicatore precoce di coxartrosi. Tuttavia, è fondamentale una valutazione clinica completa per distinguere tra le due condizioni e pianificare il trattamento più appropriato.
Sclerosi tetto acetabolare trattamento
Il trattamento per la sclerosi del tetto acetabolare dipende dalla gravità della condizione, dai sintomi e dalle cause sottostanti. L’obiettivo principale del trattamento è alleviare il dolore, migliorare la funzionalità dell’anca e rallentare la progressione della malattia.
Approccio conservativo
Generalmente il primo approccio per la terapia e il trattamento della sclerosi subcondrale è di tipo conservativo, soprattutto se i sintomi sono lievi e l’erosione della cartilagine contenuta.
I principali trattamenti conservativi per il trattamento della sclerosi del tetto acetabolare sono:
- Farmaci antinfiammatori – Riducono l’infiammazione limitando l’usura della cartilagine. Vanno a migliorare il comfort e la mobilità.
- Fisioterapia – L’obiettivo è quello di rinforzare i muscoli dell’anca, che andranno a migliorare la flessibilità e ridurre il carico sull’articolazione.
- Modifiche dello stile di vita – Il carico sull’articolazione svolge un ruolo decisivo per la salute del tetto acetabolare. Perdere peso significa ridurre il carico sull’anca. È altrettanto importante svolgere attività fisica a basso impatto per mantenere la mobilità senza stressare l’articolazione.
Infiltrazioni
Quando i tre step precedenti non hanno portato migliorie, o direttamente quando le condizioni sono più preoccupanti, si procede con le infiltrazioni all’anca.
Le infiltrazioni rappresentano una terapia conservativa comune per la sclerosi dei tetti acetabolari, mirate a ridurre il dolore e migliorare la funzionalità articolare. Ecco le principali tipologie:
- Infiltrazioni di acido ialuronico: è una sostanza naturale che lubrifica l’articolazione e ne migliora la viscosità.
- Infiltrazioni di cortisone: potente antinfiammatorio che riduce rapidamente l’infiammazione all’interno dell’articolazione dell’anca.
- Infiltrazioni di PRP: il Plasma Ricco di Piastrine, è un concentrato di piastrine ottenuto dal sangue del paziente stesso, in grado di stimolare la rigenerazione dei tessuti danneggiati e di promuovere la guarigione.
Se questo trattamento non risultasse efficace, l’eventuale intervento può essere effettuato non prima di 6 mesi.
Intervento di protesi all’anca
Tuttavia, quando il dolore diventa persistente e invalidante, limitando significativamente le attività quotidiane, o quando la degenerazione articolare è avanzata e non risponde alle terapie conservative, può essere necessario considerare un intervento chirurgico di protesi all’anca.
Ecco le principali situazioni in cui può essere indicata:
- Coxartrosi avanzata: Quando l’artrosi dell’anca ha raggiunto uno stadio avanzato, con grave usura della cartilagine e danni ossei significativi, il dolore e la limitazione funzionale possono diventare intollerabili.
- Dolore persistente e invalidante: Se il dolore all’anca interferisce significativamente con le attività quotidiane, come camminare, salire le scale o dormire, e non risponde ai farmaci, alla fisioterapia o alle infiltrazioni, la protesi può essere una soluzione.
- Limitazione grave della mobilità: Quando la rigidità dell’anca e la limitazione del movimento impediscono di svolgere le normali attività e compromettono la qualità di vita, la protesi può ripristinare la mobilità.
- Fratture dell’anca: In alcuni casi di fratture dell’anca, soprattutto negli anziani, la protesi può essere la soluzione migliore per ripristinare la funzionalità e ridurre il dolore.
- Altre condizioni: Altre condizioni che possono richiedere una protesi d’anca includono l’artrite reumatoide, la necrosi avascolare della testa del femore e alcune forme di displasia dell’anca.
La decisione di sottoporsi a un intervento di protesi d’anca è una decisione importante che viene presa in collaborazione tra il paziente e il medico ortopedico. Con l’obiettivo di alleviare il dolore e ripristinare la funzionalità dell’anca in maniera definitiva, migliorando la vita del paziente, l’ortopedico valuterà la storia clinica del paziente, analizzando sintomi ed esami radiografici, tenendo in considerazione l’età del paziente e la sua capacità di affrontare la riabilitazione post-operatoria.
Tuttavia grazie al Protocollo Requick, brevettato dal Dott. Alessandro Maria Panti, che vanta migliaia di protesi innestate, che combina una tecnica chirurgica minimamente invasiva con un protocollo di riabilitazione mirato, è possibile ottenere un recupero rapido e una gestione del dolore ottimale anche nei paziente più complessi.
L’intervento con Protocollo Requick è possibile sia per l’intervento di protesi all’anca che per quello di protesi al ginocchio.
Sclerosi del tetto acetabolare – Conclusioni
In conclusione, la sclerosi del tetto acetabolare è una condizione complessa che richiede un approccio multidisciplinare e personalizzato. Una diagnosi precoce, un trattamento adeguato e uno stile di vita sano sono fondamentali per preservare la funzionalità dell’anca e migliorare la qualità di vita dei pazienti.